Autore: Ray Bradbury
Titolo italiano: Il popolo dell’autunno
Genere: Horror / Fantasy / Fairytale Fantasy / Literary Fiction / Young Adult
Tipo: Romanzo
Anno: 1962
Nazione: USA
Lingua: Inglese
Pagine: 270
Difficoltà in inglese: ***
First of all, it was October, a rare month for boys. Not that all months aren’t rare. But there be bad and good, as the pirates say. Take September, a bad month: school begins. Consider August, a good month: school hasn’t begun yet. July, well, July’s really fine: there’s no chance in the world for school. June, no doubting it, June’s best of all, for the school doors spring wide and September’s a billion years away.
But you take October, now…
Un legame speciale unisce William Halloway e Jim Nightshade. Will, dai capelli color del grano e gli occhi chiari come la pioggia d’estate, è nato il 30 Ottobre, un minuto prima di mezzanotte; Jim, dai capelli selvatici e gli occhi verdi come l’erba, è nato il 31 Ottobre, un minuto dopo mezzanotte. Vicini di casa dalla nascita, nella sonnacchiosa cittadina di Green Town, Illinois, sono amici inseparabili, e tutto quello che sanno l’anno imparato l’uno dall’altro. Ma ora, a quattordici anni, sul finire del mese di Ottobre, la loro infanzia sta per finire.
Perché a Green Town sta arrivando il carnevale. Un carnevale itinerante che porta con sé le più bizzarre meraviglie, da un labirinto di specchi che non sembra avere fine a una vecchia cieca dai poteri sovrannaturali, e soprattutto Mr. Dark, l’impresario – un uomo dagli occhi di fuoco e con tatuaggi che gli coprono tutto il corpo, tatuaggi che sembrano vivi e si muovono con lui. Gli abitanti di Green Town cominciano a comportarsi in modo strano dopo l’arrivo del carnevale, e nonostante le proteste di Will, Jim rimane stregato da Mr. Dark e dalle energie che sembrano spirare dalle sue attrazioni. Cosa ne sarà del loro rapporto? Al compiersi del quindicesimo anno d’età, Will e Jim non saranno più gli stessi.
Di tutti gli autori associati al fantastico e soprattutto alla fantascienza, Ray Bradbury è forse il più famoso in assoluto. Ma se romanzi come Cronache Marziane e Fahrenheit 451 sono celebri anche in Italia, e se molti dei suoi racconti migliori si sono fatti largo fino nelle antologie scolastiche, questo Something Wicked This Way Comes rimane ampiamente ignorato dalle nostre parti. E dire che negli States è considerato un’opera seminale, la fonte di ispirazione dichiarata di una pletora di scrittori di horror e urban fantasy come King e Gaiman. Mi sembrava giusto, quindi, far conoscere questo romanzo e di passaggio dire la mia.
La premessa di Something Wicked This Way Comes è classica: qualcosa di caotico e maligno irrompe nella vita quotidiana, e due ragazzini si trovano soli ad affrontarlo, mentre gli adulti non sembrano rendersi conto del pericolo. Ma combattere la minaccia è anche un rito di passaggio dall’infanzia all’età adulta. La storia di Bradbury ha molto del romanzo per ragazzi, ma si capisce che vuole essere qualcosa di più; una di quelle storie di formazione che può essere letta a tutte le età e con più livelli di lettura. Vedremo se gli è riuscito.

Stanno arrivando.
Uno sguardo approfondito
Basta leggere le prime righe per rendersi conto che a Bradbury non gliene può fregare di meno dell’immersività totale, e che piuttosto appartiene alla scuola di Vonnegut e Calvino. Ecco come ci parla di Will e Jim, nel secondo capitolo, quando si incamminano verso la biblioteca pubblica: “Like all boys, they never walked anywhere, but named a goal and lit for it, scissors and elbows. Nobody won. Nobody wanted to win. It was in their friendship they just wanted to run forever, shadow and shadow.” Il suo narratore è un narratore onnisciente e invadente, che va ora da questo e ora da quel personaggio, li commetta, racconta le loro emozioni, si lancia in flashback e flashforward, snocciola raffinate metafore.
Ma se Vonnegut lo faceva per ottenere l’effetto comico, e per trasmettere un’atmosfera satirica ai suoi romanzi, Bradbury punta a fare della poesia in prosa. Sotto la sua penna, una sensazione sgradevole diventa una nuova Era Glaciale, la madre di Will diventa una rosa in una serra in una giornata d’inverno, la voce del padre una mano che si agita delicatamente in aria e il volo di un uccello bianco. Tutta una serie di personaggi – da Mr. Fury, il misterioso venditore di parafulmini fenici, a Mr. Dark, il maligno impresario del carnevale – si esprimono come poeti. Ecco il padre di Will, che di mestiere fa il bibliotecario, che saluta i ragazzi quando vengono a trovarlo alla biblioteca:
‘Is that you, Will? Grown an inch since this morning.’ Charles Halloway shifted his gaze. ‘Jim? Eyes darker, cheeks paler; you bum yourself at both ends, Jim?’
‘Heck.’ said Jim.
‘No such place as Heck. But hell’s right here under ‘A’ for Alighieri.’
‘Allegory’s beyond me,’ said Jim.
‘How stupid of me,’ Dad laughed. ‘I mean Dante. Look at this. Pictures by Mister Doré, showing all the aspects. Hell never looked better. Here’s souls sunk to their gills in slime. There’s someone upside down, wrong side out.’
In conseguenza di questo stile, tutti i movimenti e i gesti dei personaggi appaiono stilizzati, come delle coreografie, tutti i dialoghi suonano sagaci, ma artefatti. A volte così facendo, lo devo ammettere, Bradbury riesce a creare dei begli effetti; ad esempio la scena in cui Will e Jim, circondati da poliziotti nel tendone da circo del carnevale, si vedono arrivare di fronte, introdotto da Mr. Dark, il grottesco Mr. Electrico: un uomo talmente vecchio che pare morto, legato a una sedia elettrica da cui sta per partire una scarica da centomila volt. O il misterioso Mr. Fury, il venditore ambulante di parafulmini magici con iscrizioni fenicie che parla per enigmi. O la Strega della Polvere, capace di togliere la voglia di vivere agli individui con la sua sola presenza…
Certo, chi ormai si è abituato alla Bizarro Fiction o al New Weird troverà abbastanza innocue le invenzioni di Bradbury. Eppure, inserite nel contesto di tranquilla normalità di Green Town, alcune di queste colpiscono davvero. E la prosa ornata di Bradbury, benché il più delle volte non faccia altro che distrarre dalla storia, talvolta riesce ad aggiungere fascino alle sue creature.

Chi esce meglio da questo modo di scrivere, comunque, sono i personaggi. Nonostante Bradbury li presenti come degli archetipi ambulanti e li carichi di simboli (basti solo pensare ai protagonisti: il ragazzo dai capelli chiari e in ordine nato un minuto prima di mezzanotte, il ragazzo dai capelli scuri e disordinati nato un minuto dopo mezzanotte, così diversi eppure così uniti; più yin e yang di così…), hanno una loro tridimensionalità, e un carattere coerente che ci viene mostrato dai loro comportamenti, oltre che raccontato dal Narratore Onnisciente. Jim è un ragazzo impulsivo suo malgrado, prova un’attrazione incontrollabile per le ambiguità e le stranezze del mondo adulto, ma al tempo stesso se ne vergogna e vorrebbe ‘addomesticarsi’; Will invece è terrorizzato all’idea di rimanere indietro, vede Jim che si allontana verso il mondo dei grandi e si chiede perché a lui non succeda lo stesso.
Ancora più riuscito, a mio avviso, è il rapporto padre-figlio tra Will e Charles Halloway. Mentre molto del setting iniziale di Something Wicked This Way Comes sembra un idillio bucolico, la vita perfetta e stereotipica da piccola borghesia di una cittadina di campagna, il legame di Will con suo padre parte già strano. Charles è un tipo umile, stralunato, dall’aria fragile, il genere di padre per cui non puoi provare rispetto ma imbarazzo, perché sai che non sarebbe in grado di difenderti (per mancanza di coraggio o di attenzione); e lui e Will non hanno un gran rapporto. Ma gli eventi messi in moto dall’arrivo del Carnevale li avvicineranno. E il discorso di Charles Halloway a suo figlio, sul Bene e sul Male, e sul rapporto tra moralità e felicità personale, è molto più ambiguo e realista, molto più cinico di quel che mi aspettassi. Bradbury riesce a evitare di essere melenso e fasullo, e il risultato è bello.
Peccato che non duri. Il conflitto centrale del romanzo alla fine non è altro che la lotta tra il Bene e il Male; le istanze positive e negative vengono personificate, e questo lascia ben poco spazio all’ambiguità morale. I buoni non vincono con la forza, o con l’astuzia, ma per superiorità etica; e alla fine la forza per trionfare sui nemici verrà dalle emozioni. In questo si riconosce subito l’influenza che il romanzo ha avuto su scrittori come King, in cui è onnipresente il concetto di Male assoluto, e dove spesso e volentieri lo strumento per vincere il suddetto Male sono le istanze psicologico-filosofiche del protagonista piuttosto che metodi concreti. Cioè la cosa che amo di meno tanto in King quanto in Bradbury e negli altri suoi epigoni.
Uno potrebbe obiettare però che ogni scrittore nella sua opera può adottare il sistema di valori che preferisce. Per carità. Non si può negare, invece, che il plot del romanzo soffra di alcune incoerenze strutturali e occasioni sprecate. Bradbury dissemina la storia di hook che poi si dimentica di usare, e che lasciano il lettore con un palmo di naso. Il primo capitolo, per esempio, si apre (in modo abbastanza riuscito) col personaggio di Mr. Fury, che fa rivelazioni profetiche ai due ragazzi e dona loro un parafulmini dai poteri misteriosi. Tutto farebbe pensare che, per dove sono collocati e per l’enfasi che gli viene data, Mr. Fury e il suo parafulmine siano la chiave di volta della storia. Niente del genere: Mr. Fury sparisce per poi ritornare in un ruolo del tutto marginale, e il parafulmine ancestrale non servirà praticamente a nulla. Al che uno si chiede: perché sprecare un’idea così interessante? E se fin dall’inizio non aveva intenzione di utilizzarla, perché metterla in apertura del romanzo? Bradbury si rivela incapace di maneggiare i suoi stessi simboli.

Un anno e mezzo fa questa battuta era una figata.
Volendo sintetizzare il mio discorso in poche righe, Something Wicked This Way Comes è un moral play sul passaggio dall’infanzia all’età adulta. E’ un romanzo che urla ad ogni capoverso: ‘Sono una finzione! Sono un’allegoria!’, è una di quelle storie che piacciono tanto alla sinistra umanista perché suona come una parabola, e ti fa sentire così intelligente e sensibile perché la capisci. E del resto, se lo epurassimo di tutti questi elementi decorativi, quel che rimarrebbe sarebbe una storia esile e strutturata male.
Molta gente adora questo tipo di storia. Ma – benché alcune scene, dialoghi e personaggi mi abbiano colpito positivamente – io non sono tra questi. Pur riconoscendo il valore storico di Something Wicked, come fonte di ispirazione di numerosi scrittori americani contemporanei, lo trovo largamente sopravvalutato. Quanto a Bradbury, una sola delle cose che ha scritto è davvero grande: Cronache marziane. Il resto è mediocrità.
Buon Halloween!
Una considerazione su Bradbury
Mi sono sempre chiesto come mai Bradbury fosse diventato uno dei più celebrati scrittori di narrativa fantastica del Novecento. Anche il suo ruolo nella storia della fantascienza mi pare dubbio. Scrittori come Wells e Stapledon prima, e Orwell, Huxley, Asimov, Heinlein, Clarke, Dick, Ballard poi, hanno gettato nel calderone della science fiction idee che sono diventati veri archetipi del genere; delle idee di Bradbury invece, che cosa ci rimane? Lo rileva anche David Pringle, critico e direttore editoriale di riviste di fantascienza, che nel suo Science Fiction: The 100 Best Novels 1949-19841 scrive, a proposito di The Martian Chronicles: “In fact, that definition [cioè che Cronache Marziane sia un romanzo di sf] has often been disputed, since Bradbury shows no interest in science as such. His space rockets are like firecrackers; his Mars people are Halloween ghosts; while his Martian landscape is an arid version of the American mid-west”.
Forse la soluzione dell’enigma sta in questo: Bradbury ha conquistato notorietà non tanto presso i veterani della narrativa di genere, quanto presso il pubblico mainstream. E’ uno di quegli scrittori che chi non mastica fantascienza o fantasy in genere conosce benissimo. Uno di quelli che vengono lodati per la ‘potenza delle idee’, da parti di chi romanzi di idee non ne legge mai (e quindi non ne conosce gli standard). E dato che il pubblico mainstream è il Grande Pubblico, Bradbury è diventato infinitamente più celebre dei suoi colleghi rimasti nel ghetto della fantascienza. Anche se molti di quelli erano più bravi e più inventivi di lui.
E, giusto per sottolineare che non sono l’unico a pensarla così, ecco di nuovo le parole di David Pringle, questa volta in un commento a Fahrenheit 451:
“It is a rather simple-minded dystopia which Bradbury creates. […] Fahrenheit 451 is a very straightforward book, a scream of rage against the mass media and the whole 20th-century communications landscape. Television, pop music, comic books, digests, theme parks, spectator sports – Bradbury is against ‘em all, and if he had been writing this book thirty years laters he would no dobut have included video games, home computers and role-playing fantasies in his tirade. It is the litany of the old-fashioned, puritanical moralist; small wonder that the message of this novel has fallen sweetly on the ears of schoolteachers and other Guardians of Culture the world over. […] As a tract for teenagers, Fahrenheit 451 still has considerable merits, but it is scarcely a classic of adult science fiction”.

A noi piace ricordarlo così: vecchio, incazzato e un po’ rincoglionito.
Dove si trova?
Something Wicked This Way Comes è un romanzo celeberrimo, almeno nei paesi anglofoni: non avrete difficoltà a trovarlo su Library Genesis né su BookFinder, nei formati pdf e epub. Per l’edizione italiana, invece, cercate “Il popolo dell’autunno” su Emule; ma non chiedetemi chi diamine sia il genio che ha scelto il titolo italiano.
Qualche estratto
Per questo articolo, ho voluto mostrare il meglio e il peggio dello stile di Bradbury: il primo pezzo è tratto dal primo capitolo, e ci mostra l’incontro di Will e Jim con l’ambiguo Mr. Fury, e la contrattazione per dare loro un parafulmine e proteggersi dalla tempesta imminente; il secondo pezzo un lungo monologo interiore di Charles Halloway, quando nel terzo capitolo vede i due ragazzi andarsene verso casa. Se la prosa di Bradbury non vi nausea, questo libro potrebbe essere fatto per voi.
1.
 ‘Halloway. Nightshade. No money, you say?’
‘Halloway. Nightshade. No money, you say?’
The man, grieved by his own conscientiousness, rummaged in his leather bag and seized forth an iron contraption.
‘Take this, free! Why? One of those houses will be struck by lightning! Without this rod, bang! Fire and ash, roast pork and cinders! Grab!’
The salesman released the rod. Jim did not move. But Will caught the iron and gasped.
‘Boy, it’s heavy! And funny-looking. Never seen a lightning-rod like this. Look, Jim!’
And Jim, at last, stretched like a cat, and turned his head. His green eyes got big and then very narrow.
The metal thing was hammered and shaped half-crescent, half-cross. Around the rim of the main rod little curlicues and doohingies had been soldered on, later. The entire surface of the rod was finely scratched and etched with strange languages, names that could tie the tongue or break the jaw, numerals that added to incomprehensible sums, pictographs of insect-animals all bristle, chaff, and claw.
‘That’s Egyptian.’ Jim pointed his nose at a bug soldered to the iron. ‘Scarab beetle.’
‘So it is, boy!’
Jim squinted. ‘And those there – Phoenician hen tracks,’
‘Right!’
‘Why?’ asked Jim.
‘Why?’ said the man. ‘Why the Egyptian, Arabic, Abyssinian, Choctaw? Well, what tongue does the wind talk? What nationality is a storm? What country do rains come from? What colour is lightning? Where does thunder go when it dies? Boys, you got to be ready in every dialect with every shape and form to hex the St Elmo’s fires, the balls of blue light that prowl the earth like sizzling cats. I got the only lightning-rods in the world that hear, feel, know, and sass back any storm, no matter what tongue, voice, or sign. No foreign thunder so loud this rod can’t soft-talk it!’
But Will was staring beyond the man now.
‘Which,’ he said. ‘Which house will it strike?’
‘Which? Hold on. Wait.’ The salesman searched deep in their faces. ‘Some folks draw lightning, suck it like cats suck babies’ breath. Some folks’ polarities are negative, some positive. Some glow in the dark. Some snuff out. You now, the two…I – ‘
[…] ‘But which house, which!’ asked Will.
The salesman reared off, blew his nose in a great kerchief, then walked slowly across the lawn as if approaching a huge time-bomb that ticked silently there.
He touched Will’s front porch newels, ran his hand over a post, a floorboard, then shut his eyes and leaned against the house to let its bones speak to him.
Then, hesitant, he made his cautious way to Jim’s house next door.
Jim stood up to watch.
The salesman put his hand out to touch, to stroke, to quiver his fingertips on the old paint.
‘This,’ he said at last, ‘is the one.’
2.
 Watching the boys vanish away, Charles Halloway suppressed a sudden urge to run with them, make the pack. He knew what the wind was doing to them, where it was taking them, to all the secret places that were never so secret again in life. Somewhere in him, a shadow turned mournfully over. You had to run with a night like this, so the sadness could not hurt.
Watching the boys vanish away, Charles Halloway suppressed a sudden urge to run with them, make the pack. He knew what the wind was doing to them, where it was taking them, to all the secret places that were never so secret again in life. Somewhere in him, a shadow turned mournfully over. You had to run with a night like this, so the sadness could not hurt.
Look! he thought. Will runs because running is its own excuse. Jim runs because something’s up ahead of him.
Yet, strangely, they do run together.
What’s the answer, he wondered, walking through the library, putting out the lights, putting out the lights, putting out the lights, is it all in the whorls on our thumbs and fingers? Why are some people all grasshopper fiddlings, scrapings, all antennae shivering, one big ganglion eternally knotting, slip-knotting, square-knotting themselves? They stoke a furnace all their lives, sweat their lips, shine their eyes and start it all in the crib. Caesar’s lean and hungry friends. They eat the dark, who only stand and breathe.
That’s Jim, all bramble-hair and itchweed.
And Will? Why he’s the last peach, high on the summer tree. Some boys walk by and you cry, seeing them. They feel good, they look good, they are good. Oh, they’re not above peeing off a bridge, or stealing an occasional dime-store pencil sharpener; it’s not that. It’s just, you know, seeing them pass, that’s how they’ll be all their life; they’ll get hit, hurt, cut, bruised, and always wonder why, why does it happen? how can it happen to them?
But Jim, now, he knows it happens, he watches for it happening, he sees it start, he sees it finish, he licks the wound he expected, and never asks why; he knows. He always knew. Someone knew before him, a long time ago, someone who had wolves for pets and lions for night conversants. Hell, Jim doesn’t know with his mind. But his body knows. And while Will’s putting a bandage on his latest scratch, Jim’s ducking, waving, bouncing away from the knockout blow which must inevitably come.
So there they go, Jim running slower to stay with Will, Will running faster to stay with Jim, Jim breaking two windows in a haunted house because Will’s along, Will breaking one instead of none, because Jim’s watching. God how we get our fingers in each other’s clay. That’s friendship, each playing the potter to see what shapes we can make of the other.
Jim, Will, he thought, strangers. Go on. I’ll catch up, some day…
Tabella riassuntiva
(1) Di questa antologia, che ambisce a raccogliere i cento migliori romanzi di fantascienza in lingua inglese scritti tra l’uscita di 1984 e quella di Neuromante, mi piacerebbe parlarvi in un articolo futuro. Può essere un utile punto di riferimento per scoprire la narrativa del periodo, e ormai la lista di Pringle è diventata un classico.Torna su
















 Lento, il sole cala dietro le colline color cenere: le ombre si allungano, il miserabile sipario di calore puzzolente si schiude ed eccola là.
Lento, il sole cala dietro le colline color cenere: le ombre si allungano, il miserabile sipario di calore puzzolente si schiude ed eccola là.
 Autore: Jack Finney
Autore: Jack Finney



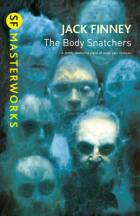

 “Esame dell’opera di Herbert Quain” è un racconto bizzarro che fa parte della famosa antologia di Borges
“Esame dell’opera di Herbert Quain” è un racconto bizzarro che fa parte della famosa antologia di Borges 










